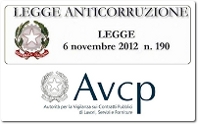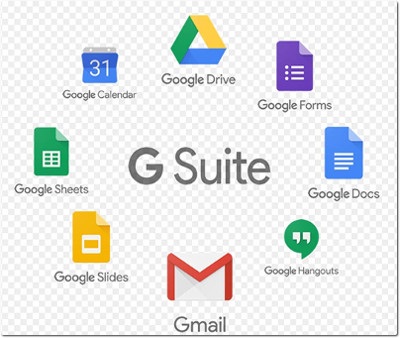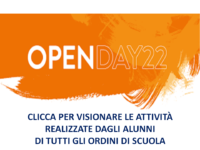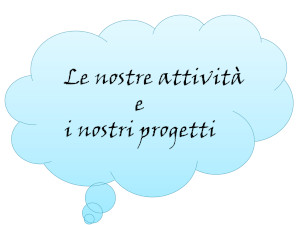Il Primo Meridiano finisce sulla cima dell’Etna
Quirico Filopanti. Chi era costui? … avrebbe detto quell’impacciato e pauroso omuncolo che personificava il Don Abbondio manzoniano e che si riflette oggi sulla maggioranza della gente, colta da un lato ma che ignora dall’altro, e che va di moda anche nel XXI secolo!
Quirico Filopanti, pseudonimo di Giuseppe Barilli (Budrio, 20 aprile 1812 – Bologna, 18 dicembre 1894), è stato un politico, astronomo e matematico italiano.
Chiunque oggi può cercare e trovare la sua vita ed i suoi scritti con una semplice ricerca su Wikipedia, ma nel nostro caso preme ricordare il suo intuito e contributo alla differenziazione dei cosiddetti “fusi orari” e per primo ardì mettere per iscritto quel meccanismo per cui fino ai nostri giorni osiamo -nella più totale innocenza- continuare a dividere la nostra madre Terra in “spicchi”, come gli agrumi siciliani, quelle buone arance che profumano di zagara!
Nella sua opera Miranda risalente al 1858 propose infatti per la prima volta i fusi orari. L’ipotesi di Filopanti era proprio quella di suddividere idealmente la terra in corrispondenza dei meridiani [circonferenze immaginarie che si ottengono dall’intersezione tra la superficie terrestre e piani passati per i due poli] in ventiquattro zone (fusi) a ognuno dei quali avrebbe dovuto corrispondere un orario. Ogni fuso avrebbe dovuto differire dal successivo di un’ora, mentre avrebbero coinciso i minuti e i secondi. Il primo fuso avrebbe dovuto essere centrato sul meridiano di Roma, ma divenne ben presto appannaggio anglosassone manifestandosi nel cd. meridiano di Greenwich, che oggi (sommerso da visitatori) continua ad essere il circolo massimo meridiano avente per convenzione longitudine pari a zero, passante appunto per l’osservatorio di Greenwich a Londra. La suddivisione in fusi avrebbe determinato il tempo locale (L). L’ipotesi prevedeva anche la determinazione di un tempo universale (U) che si sarebbe dovuto utilizzare come riferimento unico nell’astronomia e nelle comunicazioni telegrafiche.
Ma tornando a noi, cosa accomuna dunque Budrio (città natale di Filopanti), a Nicolosi (cittadina del catanese con territorio posto fin sulle cime del monte Etna) e Londra (con la sua Greenwich -a riferimento internazionale- quale punto zero dei meridiani)?
Naturalmente … I FUSI ORARI!
Il sistema dei Fusi Orari, ideato e proposto nel 1859 dall’italiano Quirico Filopanti, è stato di fatto adottato su scala internazionale dopo le due conferenze dell’ora: 1884 a Washington e 1913 a Parigi. Il sistema, studiato anche a scuola, prevede la suddivisione della Terra in 24 Fusi Orari. Ogni Fuso ha una ampiezza di 15° ed in tutto il suo territorio vige la stessa “ora civile” (quella segnata dagli orologi meccanici e regolata dal passaggio del sole sul meridiano centrale). A partire da Greenwich, per l’Italia vale il <Fuso 1° EST> che va da Longitudine +7° 30’ a Longitudine +22° 30’. Lo stesso vale per l’Europa Centrale e per molte nazioni dell’Africa Occidentale. Il meridiano centrale di questo fuso è il 15° (quindicesimo). Esso attraversa appunto il Monte ETNA in un punto ben preciso e per ciò è detto anche “Meridiano dell’ETNA”.
Ad essere precisi il Meridiano 15 passa circa 300 metri ad est del centro del Cratere di Nord-Est, 450 metri ad est del centro della Voragine ed esattamente sul Cratere della Sella, tra il “vecchio” Cratere di sud-est (CSE) ed il “nuovo” (NCSE).
L’Italia appartiene tutta al primo fuso, che ha per meridiano centrale quello passante per Termoli, sull’Adriatico, e per il cratere dell’Etna, per cui il tempo civile italiano, che è il Tempo Medio dell’Europa Centrale (TMEC), prende anche il nome di tempo medio dell’Etna.
Da questa suddivisione territoriale strategica vengono fuori dei prodotti tipici ed unici che in Sicilia prendono il nome e la vigoria del monte Etna, da molti visto come improduttiva e sterile “sciara” (pietra lavica raffreddatasi). Con tali proprietà non è un ambiente ideale per la crescita delle piante. Sul suolo vulcanico si trovano sostanze che provengono dal centro della Terra, espulse a elevate temperature durante le eruzioni e poi depositate a terra. Non è un ambiente in cui i microrganismi possono vivere facilmente.
Tuttavia l’Etna è pietra viva sia quando è incandescente nella sua colata lavica, sia quando dà forza e vita a prodotti della natura non limitati alla sua flora e fauna, ma ai suoi frutti originati da un terreno ricco di Sali minerali presenti negli organismi.
Quelli vulcanici sono, infatti, dei terreni estremamente mineralizzati, ricchi di elementi di vitale importanza per le piante e, in modo particolare, per i vigneti ed uliveti. La viticoltura vulcanica è un filone in grande crescita ed espansione a livello internazionale, ma dotato di grande forza attrattiva anche nel nostro Paese. Ciò che differenzia e caratterizza i vini vulcanici italiani è, infatti, la loro provenienza da viti storicizzate, non coltivate con un approccio industriale.
Il terreno lavico-alcalino dell’Etna consente la coltivazione di tre vitigni autoctoni: i rossi, nerello mascalese e nerello cappuccio, e il bianco carricante.
I territori vulcanici in genere, non solo quello etneo, sono storicamente noti infatti per la fertilità e per l’abbondanza di componenti alcalini e ferrosi che permettono di conferire alle uve che vengono coltivate su questi suoli degli aromi decisamente particolari, impossibili da riscontrare in vini provenienti da altri terreni con caratteristiche diverse. L’elevata concentrazione in potassio, fosforo, zolfo e magnesio li rende infatti non paragonabili con nessun altro terreno calcareo, morenico o metamorfico. I suoli costituiti da rocce vulcaniche hanno, inoltre, valori più elevati di macro-porosità che gli consentono di immagazzinare grandi quantità di acqua, anche nelle stagioni più secche. I vini vulcanici, quindi, vini etnei compresi, e gli oliveti godono senz’altro dei benefici derivanti da queste caratteristiche naturali.
Ogni qualvolta si verifichi dell’attività esplosiva il vulcano “concima” naturalmente le sue pendici. L’attività esplosiva, infatti, provoca una ricaduta di cenere ai piedi del vulcano che, se in un primo momento può produrre dei danni ai frutti che sono già sulla pianta, in realtà nel medio e nel lungo termine permette di rivitalizzare il suolo con sostanze nutritive molto importanti: è come se il vulcano periodicamente “riconcimasse” i suoi terreni e li rendesse nuovamente fertili.
Da qui – e dalla particolarità del MERIDIANO DELL’ETNA – vengono fuori nondimeno <L’Etna Rosso Longitudo15> premiato nella ottima vendemmia 2015 dalle vigne centenarie prephilloxera dal più conosciuto vigneto dell’Etna: Il Nerello Mascalese, antico vitigno a bacca rossa autoctono, coltivato a piede franco sui terrazzamenti vulcanici dell’Etna a quota 800 m.s.l.m.. Vino altamente pregiato per le sue tecniche di produzione e lavorazione legate ai vecchi vignaioli della montagna, prende il suo nome dal “meridiano dell’Etna” che passa per Randazzo ed attraversa le nostre vigne nel 15° 00’ 00’’ di longitudine est da Greenwich (Meridiano 0). Del Longitudo15 vengono prodotte 5720 bottiglie esclusive numerate, edizione limitata, collocate in pregiate cassette di legno da 6 bottiglie da 750 ml. Un vino vera espressione del “terroir” vulcanico.
Ovvero non da meno si erge anche l’olio extravergine di oliva Monte Etna DOP (olio dell’ETNA – XV° Meridiano Etna Island Nicolosi (CT). Gran Menzione. Frantoio Tini Sas) ottenuto dai frutti dell’olivo della varietà Nocellara Etnea, presente negli oliveti in misura non inferiore al 65%. Possono concorrere altre varietà presenti nella zona quali Moresca, Tonda Iblea, Ogliarola Messinese, Biancolilla, Brandofino e Olivo di Castiglione, fino a un massimo del 35%.
In fin dei conti anche il meridiano dell’Etna può essere gustato da tutti ed in qualsiasi momento nella sua classica ed inconfondibile naturalezza.
Del meridiano dell’Etna ne parla il romanzo “Un po’ a sinistra del meridiano dell’Etna” edito da Prova d’autore nel 2021, ove nel suo racconto l’autore Vincenzo Spampinato mette in evidenza la distruzione e il ritrovamento nel territorio di Nicolosi, proprio nel cuore del Parco Naturale dell’Etna, di un importante osservatorio astrofisico “Bellini” che diventa il simbolo non solo della relazione padre-figlio ma anche in senso più ampio della inscindibile relazione della popolazione con la loro madre “ ‘a Muntagna” cioè l’amata Etna.
Maria Nicolosi
Photogallery